Plauto, commediografo del II sec. a.C., fu un autore molto prolifico: alla sua morte, avvenuta nel 184 a.C., circolavano ben 130 commedie associate al suo nome. Per questo motivo, già nel I sec. a.C., all’inizio della filologia latina, molti eruditi si trovarono di fronte al problema di sbrogliare questa complessa tradizione di commedie: quante erano autentiche? Quante, invece, erano attribuite a Plauto senza essere originali? L’autore che riuscì a dare una risposta, condizionando interamente la quantità di commedie plautine giunte fino a noi, fu Varrone.
Indice dell'articolo
La filologia a Roma
Risolvere il problema della tradizione di Plauto non era affatto semplice. Già gli eruditi di poco successivi a Plauto sapevano che, per la fama del commediografo, tanti altri autori si erano ispirati a lui falsificando il nome e attribuendo a Plauto le loro commedie. Ma non solo: molte commedie, questa volta davvero di Plauto, erano state oggetto di dubbio poco dopo la sua morte oppure, nonostante il loro evidente stile “plautino”, erano state attribuite ad altri commediografi. Il lavoro filologico, dunque, era davvero complesso.
La filologia nacque a Roma a cavallo tra II e I sec. a.C. Poco prima, ad Alessandria d’Egitto, aveva lavorato il più grande filologo e commentatore dell’antichità: Aristarco di Samotracia. Elio Stilone, vissuto una generazione dopo Plauto, “importò” a Roma i metodi filologici di Alessandria e Pergamo e li applicò per la prima volta proprio alla tradizione plautina.
Elio Stilone, il primo filologo
È sorprendente pensare che, poco dopo la morte di Plauto, la tradizione delle sue commedie fosse già così intricata. Elio Stilone lesse le commedie di Plauto secondo la prassi alessandrina: mentre la filologia a Pergamo era di indirizzo “allegorico” (leggeva, cioè, la letteratura tentando di scovare significati sottesi), quella alessandrina era di stampo “linguistico”. Per questo motivo Elio Stilone si concentrò sulle parole delle circa 130 commedie attribuite a Plauto, ed eliminò le opere che, a suo parere, non rispecchiavano il tipico stile “plautino”. Nel suo Commentarium de proloquiis, così, arrivò ad un totale di sole 25 commedie autentiche: una scrematura non indifferente.
L’allievo Varrone: il De comoediis plautinis
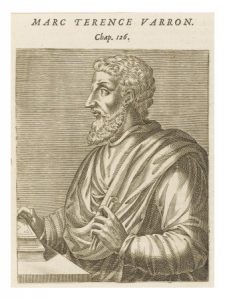 Tra gli allievi di Elio Stilone vi furono Cicerone (che però non continuò gli studi filologici) e Varrone, il quale, addirittura, riuscì a superare il suo maestro. Divenuto ben presto grandissimo erudito ed esperto di letteratura, decise di approcciarsi a sua volta alle commedie di Plauto, non essendo convinto della scelta di Elio Stilone. Scrisse, così, un De comoediis Plautinis, nel quale, alla stessa maniera del maestro, analizzò la produzione di Plauto sulla base dello stile e della verve comica. Il risultato fu che, a differenza di Elio Stilone, Varrone ritenne autentiche solo ventuno commedie di Plauto. Altre diciannove furono considerate “incerte” e il resto fu accantonato come spurio.
Tra gli allievi di Elio Stilone vi furono Cicerone (che però non continuò gli studi filologici) e Varrone, il quale, addirittura, riuscì a superare il suo maestro. Divenuto ben presto grandissimo erudito ed esperto di letteratura, decise di approcciarsi a sua volta alle commedie di Plauto, non essendo convinto della scelta di Elio Stilone. Scrisse, così, un De comoediis Plautinis, nel quale, alla stessa maniera del maestro, analizzò la produzione di Plauto sulla base dello stile e della verve comica. Il risultato fu che, a differenza di Elio Stilone, Varrone ritenne autentiche solo ventuno commedie di Plauto. Altre diciannove furono considerate “incerte” e il resto fu accantonato come spurio.
Le scelte di Varrone hanno influenzato non poco la tradizione di Plauto. L’erudito mise un punto alla questione plautina e più nessuno osò metterci bocca. Il risultato? Le commedie di Plauto che son giunte fino a noi sono solo quelle ventuno. Ma Varrone aveva davvero ragione?
Aulo Gellio: la rivalutazione nelle Noctes Atticae
È chiaro che ventuno è un numero troppo misero se paragonato alla fama di Plauto: le sue commedie dovevano essere molte di più. Molti eruditi di gran lunga posteriori a Varrone, infatti, criticarono in parte il suo lavoro. Uno di essi fu il per noi preziosissimo Aulo Gellio, autore di II sec. d.C.
Aulo Gellio è noto per le sue Noctes Atticae: in quest’opera egli riporta le “chiacchierate” svoltesi ad Atene durante i banchetti tra eruditi ed esperti di letteratura. Gli argomenti, dunque, vanno dal diritto all’architettura sino all’arte e alla critica letteraria.
Aulo Gellio riprese, così, anche il problema della tradizione plautina. Nonostante la “scrematura” effettuata da Varrone, molte altre commedie di Plauto erano sopravvissute fino all’epoca di Gellio, il quale era solito leggerle e commentarle col suo maestro Frontone. Frontone era così esperto di letteratura che, al solo ascoltare un verso di commedia, era in grado di riconoscere se questo era plautino oppure no. Ebbene, Gellio racconta che nelle loro letture maestro e allievo avevano spesso rivalutato commedie che da Varrone erano state reputate incerte ma che, a loro parere, erano palesemente plautine. Gellio, dunque, riconosceva non pochi errori a Varrone, soprattutto per le commedie incerte.
L’impronta della filologia
Nonostante gli sforzi di Gellio, le commedie probabilmente plautine ma assenti nel canone delle ventuno sono scomparse lungo la tradizione. Ciò avviene spesso in filologia quando grandi nomi intervengono sulla tradizione di autori precedenti e la condizionano: basti pensare a come i canoni bizantini abbiano influito sulla trasmissione dei tragici greci, selezionando solo sette tragedie per ciascuno (di Euripide ne abbiamo di più solo per il ritrovamento casuale di un manoscritto).
Il lavoro filologico, dunque, è tanto importante per noi quanto pericoloso talvolta: può, infatti, compromettere per sempre la conoscenza che i posteri avranno sugli autori del passato.
Alessia Amante

